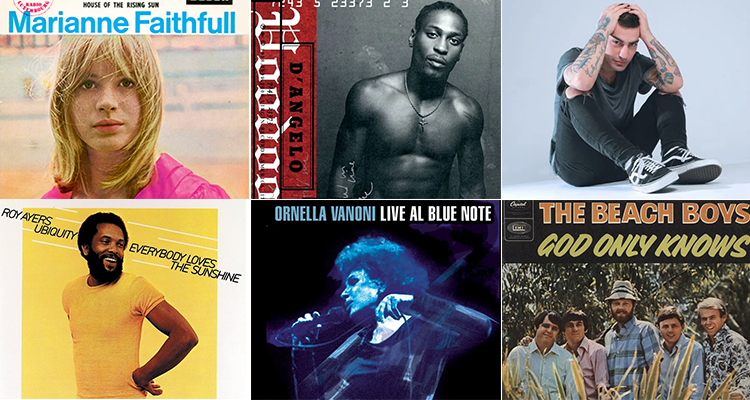A giugno ero a Pescara per girare un reportage di lavoro. Andarci in treno, come abbiamo fatto, è sempre bello perché da Rimini in poi si viaggia spesso in riva al mare, già con le prime persone al bagno per l’inizio di stagione. In certi tratti ti sembra quasi di poterle toccare, tanto il treno corre accanto a porzioni di spiaggia. Oppure, immagini chi si sta preparando per una battuta di pesca dentro i capanni sull’acqua che appaiono mentre si sta arrivando ad Ancona.
A fine riprese, è successo un episodio nato come semplice pour parler, ma che mi ha riportato a tempi passati.
Mentre aspettiamo un taxi per andare a fare altre riprese lungomare, un collega che avevamo filmato poche ore prima mi dice che per lui “la dorsale Adriatica è un po’ come fosse l’Italia”.
Ne rimango colpito. Anzitutto, perché è vero.
L’Italia – purtroppo, per certi versi – è lunga e stretta e attraversarla percorrendo l’Adriatico o il Tirreno è un’esperienza che ti fa capire la sua diversità man mano che i chilometri aumentano, in un senso di marcia o nell’altro.
Ma attraversare, davvero, l’Italia lungo la dorsale Adriatica come facevo io da ragazzino per andare da Torino, estremo nord ovest, fino a Otranto, il tacco dello Stivale, per tutti gli anni’80, è qualcosa che avevo riposto in un angolo del mio cervello e che il mio collega ha fatto riaffiorare.
I primi anni andavamo in auto, tagliando l’enorme pianura a fianco della via Emilia, tra stabilimenti di ceramiche, odore di mangime per maiali e autogrill dove potevi trovare improvvisati venditori di orologi d’oro rubati in Svizzera.
Passata la Romagna, iniziavano le colline marchigiane e tratti di strada più in altura. E lungo tutto il percorso, da Rimini fino a Bari, le file di oleandri bianchi e rosa accanto al guard-rail, che resistevano a velocità delle auto, gas di scarico, vento di scirocco. Un serpentone floreale di centinaia di chilometri.
Verso il tramonto si superava il confine tra Molise e Puglia, sfrecciando in mezzo a una piana che a me pareva il deserto, per giungere a Foggia e sostarci per dormire. Faceva sempre un gran caldo: era passato da poco ferragosto e i locali non erano ancora così climatizzati, ma si andava di ventilatori o pale. Ricordo una pizzeria rumorosa, con al centro un televisore ancora in bianco e nero che radunava un gruppo di fan a guardare un varietà sulla Rai, come fossero ancora i tempi di Lascia e raddoppia.
Anche al ritorno ci fermavamo a dormire, a Rimini. Era metà settembre, la stagione era terminata e andavamo alla ricerca di qualche pensione ancora aperta. Odore di ragù troppo cotto e di materassi ormai al capolinea. La mattina del 15 settembre 1982, mentre ci sedemmo per fare colazione, arrivò la signora della pensione a dirci: “È morta Grace di Monaco.”
Qualche anno dopo, iniziammo invece ad andare in treno, con l’auto al seguito, il che significava andare in stazione a Torino parecchio tempo prima della partenza per caricare l’auto sui vagoni, sperando di ritrovarla intera la mattina dopo. Il viaggio era notturno, in cuccette da sei posti, su treni che oggi non esistono più e che ho ritrovato, molti anni dopo, quando viaggiavo sull’Euronight Venezia – Budapest per andare a Zagabria (ne ho scritto qui).
Quando, finalmente, lo scompartimento decideva che fosse terminato il momento delle chiacchiere – che, già da ragazzino, non amavo – e che ci si coricasse in branda, si provava a dormire nonostante i rumori di un Intercity, le fermate notturne e il provare a guardare dal finestrino dove fossimo. Ciò che ricordo bene è lo svegliarsi la mattina presto, verso le sei, con le luci dell’alba e le onde del mare di fronte a te, come stesse per entrarti nello scompartimento. Si era già oltre Pescara e si correva, per modo di dire, verso Vasto per poi osservare all’orizzonte il borgo antico di Termoli.
Il treno terminava a Bari. O meglio: per le auto al seguito, bisognava scendere alla stazione di Bari Parco Sud e attendere, a volte ore, in mezzo al nulla, per poi finalmente vedere arrivare, sbuffando, i vagoni con le auto che avrebbero di nuovo toccato terra per proseguire un viaggio che sarebbe durato, ancora, almeno un paio d’ore, percorrendo quella che all’epoca era una statale stretta e pericolosa, ma che attraversava case bianche senza tetto, uliveti meravigliosi e una terra rossa, come quella dei campi da tennis, che non avevo mai visto prima e che ancora oggi rimane una mia madeleine.
Da Torino a Otranto era, ed è, davvero l’Italia, in un continuum tra due punti tanto diversi quanto ugualmente italiani. Otranto, così all’estremo lembo orientale, così levantina, così proiettata verso la riva opposta dell’Adriatico, aveva, e ha, tutto il mio interesse. Oltre a essere stata la vacanza della mia adolescenza e non solo, perché ci sono poi, più volte, ritornato, anche se appunto in altri tempi e con mezzi di trasporto ben più comodi.
Probabilmente, come spesso accade, se ci tornassi ora ne rimarrei (magari soltanto in parte) deluso. Ma va bene così. Tornando indietro nel tempo, sono stato felice di aver scoperto la sera della prova generale della notte della Taranta a Melpignano, ignorando cosa fosse, ben prima che diventasse un fenomeno di costume. Sono stato felice di aver perlustrato quei chilometri di costa e di dune ben prima dell’avvento degli stabilimenti di massa e dei parcheggi a pagamento. In sostanza, sono stato felice di aver scoperto, a undici anni, il punto estremo di un viaggio che spiega, bene, molti aspetti del nostro Paese.
Adriatico, Italia.
Post scriptum.
Tre brani dei primi anni’80 tra i vari che potevo scegliere:
Culture Club, Miss me blind
Franco Battiato, Summer on a solitary beach
a-ha, The sun always shines on tv